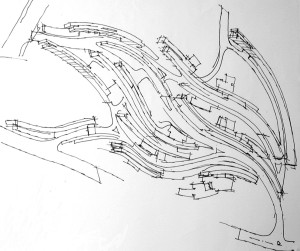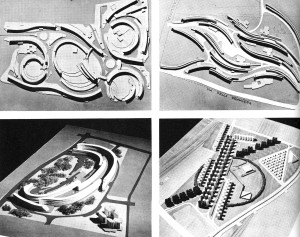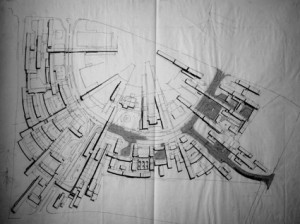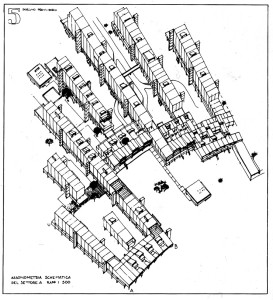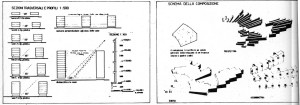di Giuseppe Strappa
in «Metamorfosi» n° 67 del luglio/agosto 2007
Venivano giù da un grande oblò rugginoso. Balcanici con gli occhi nascosti da pesanti schermi ottici, grassi cinesi con pantaloni di pelle colorata, un gruppo di tecnici del Nuovo Kerala con i loro copricapo in penne di fagiano. Poggiavano appena il piede sul terreno e già sollevavano lo sguardo impaziente verso la collina, come per porre fine a una lunga attesa.
Cupa e solenne contro il cielo limpido di dicembre, avvolta alla base da muschi e licheni, appariva la Rovina. Smisurata, enigmatica.
Alcuni piani erano crollati all’inizio del terzo millennio per l’incuria degli abitanti, ma la sagoma originale s’intuiva ancora, nonostante le vistose lacune riempite dall’azzurro del cielo. Verso sud, invece, la figura si rompeva contro la luce e lasciava indovinare le infinite aggiunte che si erano stratificate nel tempo, come una spessa crosta, sulle strutture di cemento: costruzioni difensive in resina di reimpiego e pesanti piastre di ferro dalla splendida ossidazione, tutelate dalla Suprema Intendenza Regionale fin dall’anno dei primi restauri, risalenti ormai al 2273.
Con fatica il gruppo prese a muoversi tra la selva di bottegucce spuntate come funghi ai piedi dello sito archeologico. Cumuli di montanti in verbonio e logori teli di kuplar si univano a formare una bazar fluido, in eterna trasformazione, dove industriosi immigrati celtici vendevano ogni genere di souvenir.
Anche i rumori si fondevano in un solo brusio di fondo. E su tutto aleggiava, tristissima e misteriosa, la nenia di un piccolo cantastorie irlandese. Le note si avvitavano leggere alle spire di fumo dei bracieri e poi salivano, insieme, verso il sole.
“Ho visto cose che voi umani non potreste immaginare. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhauser…. Ma mai, mai avrei pensato di vedere uno spettacolo tanto fastoso e potente, le nostre radici autentiche celebrate da questo glorioso monumento in rovina”.
Il ballerino rumeno che aveva pronunciato queste parole era stato evidentemente rapito da un trasporto eccessivo. Eppure le sue esagerazioni non mancavano di una qualche giustificazione.
Perché da tempo, ormai, Corviale non era più soltanto un luogo fisico. Era soprattutto un luogo della mente, una zona molteplice e universale, dove si era concentrato, accavallato, rifuso per secoli ogni tipo di leggende, alimentate dal proliferare di siti dedicati, sui quali si tenevano in esercizio perditempo informatici di tutti i paesi.
Da quando la Rovina era divenuta il caso di studio d’elezione nei principali congressi sulla fine (la fine della modernità, la fine dell’architettura, la fine del racconto) aveva costituito il terreno di prova dei più ostinati falsari di documenti.
Da principio si trattava di contraffazioni piuttosto rozze, al limite del dilettantesco, sfornate da giovani ricercatori delle università terrestri, ansiosi di pubblicare inediti su un argomento ormai conosciutissimo. Ma, col tempo, veri professionisti della falsificazione, non di rado insospettabili docenti di chiara fama in pensione, cominciarono a sfornare falsi impeccabili che avrebbero sfidato le verifiche più sofisticate. Si finì, così, col dubitare perfino dell’attribuzione dell’opera, mettendo in dubbio l’esistenza stessa dell’architetto che l’aveva ideata, il quale sarebbe stato un personaggio d’invenzione, simbolo fantastico e sintetico di una miriade di contributi che si sarebbero succeduti nel tempo.
Il colpo di grazia alle certezze storiche sulla grande opera arrivò verso la metà del primo secolo del terzo millennio, quando un’ondata di virus autoramificati sì abbatté sugli archivi informatici superando tutti i sistemi di sicurezza che li difendevano, infettandoli in modo irreversibile. Non solo danneggiarono i preziosi documenti sull’origine e le trasformazioni della Rovina, ma li corrosero dal di dentro,deformando e trasformando i significati delle testimonianze nel loro opposto. Non si riusciva più a distinguere il vero dal verosimile, l’autentico dalla copia. Allora si tentò di rintracciare gli originali nel GDC, nel Grande Deposito Cartaceo nazionale. Ma ci si accorse, con orrore, che il contenitore sepolto a gas ionizzato destinato alla loro conservazione era stato violato e tutto il contenuto trasformato in un mucchietto di cenere.
Corviale era così divenuto un luogo virtuale, un’immaginaria regione germinale della cultura occidentale affollata di simboli d’invenzione opposti e deformi, dove ogni comunità ritrovava coesione e confini riconoscendovi, come in uno specchio, le proprie ansie, allucinazioni, speranze.
E nel deserto della memoria cominciarono a sorgere fantasmi e visioni. Paure che sembravano sopite e che attendevano, invece, in agguato nel fondo delle coscienze uscirono urlando alla luce del sole.
I documenti non hanno mai provato, ad esempio, che ci fosse il minimo fondamento di verità nella leggenda della banda di peruviani che avrebbe ammaliato gli ottomila abitanti di Corviale suonando tutta la notte i loro cajòn e flauti di Pan, attirandoli fuori, nei prati bui, per poi massacrarli all’alba, ad uno ad uno, per rubargli la casa.
Alcuni, incerti riscontri di questi fatti sembravano provenire dallo studio della glittica delle antiche migrazioni latino americane, ma si scoprì in seguito che i sigilli rinvenuti nei piani bassi della Rovina non erano che falsi creati ad arte con vecchie macchine a controllo numerico. Nondimeno la storia, per quanto inverosimile, fu presa per vera, e si trasformò in una sorta d’indiscutibile tragedia sepolta nella storia metropolitana utile a giustificare odi inconfessabili seguiti dagli attacchi più vergognosi, le scorrerie più feroci e sanguinarie contro le inermi comunità che si erano rifugiate tra i ruderi.
Allo stesso modo non poggia su alcuna base scientifica la convinzione, pure caparbiamente sostenuta da illustri accademici, che il progetto di Corviale contenesse un anatema genetico o che un incantesimo avesse dilatato la scala della costruzione fino a farla sfuggire di mano agli architetti, come una nuova Torre di Babele in pannelli prefabbricati.
Doktor Sötil, la guida, con la miscela di ovvietà ed arguzia del consumato affabulatore, espose tutto questo velocemente ai visitatori ben sapendo che si trattava, in fondo, di argomenti piuttosto noti.
“Gli elementi principali dei fatti che determinarono la trasformazione di Corviale – aggiunse osservando con imbarazzo la punta dei propri stivali – sono, ad ogni modo, certi.”.
Fingendo di non udire il brusio di scetticismo che le sue parole avevano suscitato, proseguì, indicando le rovine “Questo, cari signori – la voce era divenuta di colpo stentorea – doveva essere l’inizio di una nuova era! Certo, di una nuova era felice! Era stato immaginato come uno smisurato, geniale magnete, la rappresentazione della catarsi delle tragedie urbane del XX secolo. Ebbene, per soli dodici copechi io vi guiderò tra i resti di questo sogno meraviglioso, di questa secolare utopia.”
I turisti, tutt’altro che sorpresi, sfilarono pazientemente davanti all’improvvisato condottiero. Le dodici monete cadevano nella sudicia bisaccia che la guida si era affrettata a spalancare, una ad una, risuonando.
Il gruppo si avviò su per la collina evitando i venditori di infusi e la selva di bambini che si affollavano chiedendo il bakshish.
Entrarono nell’interno semibuio della Rovina squarciato da improvvise lame di luce, attraverso una delle cinque fessure che si aprivano come ferite sulla facciata continua della costruzione. I tralicci, che un tempo sorreggevano i cilindri traslucidi delle scale, si proiettavano sconsolati nel vuoto.
Iniziarono ad aggirarsi, piccoli viventi tra le auguste macerie, quasi con timore, come in un’incisione piranesiana.
La guida mostrava pazientemente quello che rimaneva dei diversi piani, i resti delle cellule abitative che componevano l’immenso organismo e le presunte ragioni del suo declino biologico. Spiegava, con notevole competenza, la differenza tra le case, ormai vuote, poste ai piani bassi e quelle ai piani alti e la probabile funzione del livello intermedio di servizio, il più devastato per essere stato a lungo il terreno di scontro tra le diverse fazioni in cui si erano divisi, nel corso dei secoli, gli abitanti.
Parlava di getto e quasi correva temendo di non terminare prima del buio. Ma si fermò in improvviso raccoglimento di fronte ad un grande vuoto dove resti incomprensibili e muti sembravano testimoniare un antico disastro. Era evidente come alcuni piani fossero crollati già quando la costruzione era abitata (la guida ne attribuì la causa alle disastrose dilatazioni termiche negli anni del Grande Riscaldamento della crosta terrestre) formando una strana cavea circondata da terrazze.
Lo spazio che precipitava tra solai spezzati e monconi di ferro, chiuso in alto, chissà quando, da una copertura di fortuna, aveva generato un singolare microclima che favoriva la crescita di specie vegetali insolite per le nostre latitudini. Come la rara Chamaedorea oblongata, palma da tempo ritenuta estinta, e felci straordinariamente rigogliose, soprattutto inconsuete varianti (ma qualcuno parlava di deformazioni genetiche) della famiglia delle epifite, particolarmente delle Platyceria willinckii. Si era così formato, nel grembo più segreto ed oscuro della Rovina, un curioso orto botanico al quale i visitatori si accostavano sempre con rispetto e timore. Un luogo curioso ed umido, di grande valore didattico, che aveva acquistato nel tempo un proprio pubblico di affezionati frequentatori.
Ma sul fondo buio e fradicio della cavità, mai visitato per secoli da essere umano, si intuiva lo sviluppo abnorme di alcuni vegetali carnivori, mostruosi d’aspetto, che si diceva provenissero da un pianeta misterioso e lontano. I vecchi raccontavano come, molti anni addietro, la Croce del Sud, la nave spaziale più gloriosa e più bella della flotta pontificia, avesse planato lungo la costa del Tirreno con i motori in fiamme, ondeggiando come un uccello ferito, per poi virare di novanta gradi all’altezza di Roma nel disperato tentativo di compiere un atterraggio di fortuna.
La massa gigantesca aveva lasciato un solco di tre leghe lungo la pianura fino a fermarsi, smisurato mostro sbuffante ed esausto, proprio ai piedi della collina. Uno dei motori si era staccato dalla carlinga rotolando lontano e ora giaceva desolato come l’artiglio di un misterioso animale ucciso. Nessuno sapeva da quale viaggio la nave tornasse. Molti testimoni, tuttavia, giuravano di aver visto l’unico sopravvissuto, con il volto ustionato, uscire dal relitto fumante e trascinarsi con un sacco sulle spalle fino al piano interrato della Grande Rovina. Quel sacco avrebbe contenuto i semi delle piante carnivore, come se il superstite, prima di morire, avesse voluto che la vita e la leggendaria epopea della Croce del Sud dovessero, in qualche modo, continuare. Ancora non era noto, comunque, come questo mondo vegetale in continua trasformazione si sarebbe evoluto.
In alto, tra le liane che pendevano dai solai crollati, era stato ricavato un tempietto sormontato da un timpano. La Madonna dell’Ozono vi era raffigurata, al centro, con le mani giunte e gli occhi rivolti al cielo, nell’atto di salvare Corviale, riprodotto in maiolica ai suoi piedi, dalla tragica ondata di calore che si era abbattuta su Roma, uno dei sette flagelli del XXI secolo che aveva distrutto quasi tutta l’edilizia costruita dall’IACP a partire dalla metà del secolo precedente.
Il breve, silenzioso raccoglimento, costituì il necessario intervallo prima di ammirare i resti più appassionanti e discussi: i lunghi percorsi dalle prospettive vertiginose che ribaltavano all’interno dell’edificio il comportamento della città tradizionale del XX secolo, con le abitazioni allineate lungo un percorso pubblico e spazi condivisi per la sosta e il divertimento.
I visitatori si spinsero fino al termine di uno dei percorsi interni, poi si mossero lungo un altro, in senso inverso, fino alla fine. Verificarono con cura, dopo un chilometro di cammino, quello che tutti conoscevano: la strada non portava da nessuna parte. E si chiesero, per l’ennesima volta, come una città potesse iniziare dal nulla e finire nel nulla.
I visitatori attesero, incuriositi, l’interpretazione della guida.
“Per molto tempo si è pensato che l’edificio non potesse finire qui, che il percorso interno dovesse pure portare da qualche parte, come sarebbe stato logico.” Doktor Sötil parlava ora a bassa voce, quasi stesse facendo una confidenza più che dare una spiegazione. “Un percorso senza conclusione era, perfino per i moderni del XX secolo, qualche cosa che ripugnava, contro natura.
Vedete quelle grandi buche? Si è scavato molte volte a ridosso delle testate della Rovina cercando una traccia, una spiegazione ma, ogni volta, senza risultato. Brutus Bernstein, all’inizio del XXII secolo, pubblicò un’ingegnosa ipotesi ricostruttiva che mostrava due gigantesche sfere in calcestruzzo sulle opposte testate dell’edificio. Dovevano essere, secondo l’illustre teologo armeno, i poli, antitetici e complementari, delle percorrenze interne, i quali rappresentavano l’ineffabile armonia delle sfere celesti. Corviale sarebbe stato la riproduzione della Città di Dio, microcosmo concluso e autosufficiente dove una rigida regola monastica avrebbe dovuto governare la vita degli abitanti.
Il glorioso Zetema W. Pecorella coltivò a lungo, invece, la suggestiva congettura che quello che vediamo ora non sarebbe che il moncone, solitario e muto, di un’immensa città lineare che doveva arrivare fino al mare. Per anni devastò con infiniti scavi la piana tra il vecchio quartiere Aurelio e la costa di Castelfutzano alla ricerca di evidenze archeologiche che confortassero la sua avventurosa teoria. Finché un’insurrezione dei contadini che abitavano le terre intorno ai resti di Caval Palocco, esasperati dalle continue perdite del raccolto, non lo costrinse a desistere.
Anni dopo, quando gli uomini riuscirono a riflettere senza pregiudizi sulle due inconciliabili teorie, si capì che si trattava comunque di bambagia storica, di due soluzioni consolatorie al problema, un’ultima, disperata barriera della coscienza che non voleva ammettere l’evidenza: che la ragione non appartiene al Razionale, anche, e forse soprattutto, in architettura.”
Non tutti approvarono le parole piene di convenzionale saggezza della guida, ma ne apprezzavano, col progredire delle spiegazioni, la grande competenza e chiarezza. Solo un rotondo agrimensore del Regno Cristiano del Quebec, ultima isola francofona nel gran mare neocinese, sembrava non capire.
La visita si avviava alla conclusione. L’azzurro del cielo, che appariva di quando in quando tra scale crollate, polverosi scaffali vuoti e vecchi vasi di plastica, si andava trasformando in un bagliore opalescente e diffuso.
I visitatori, esausti per i tanti corridoi, sentieri labirintici e ballatoi percorsi, approdarono al tepore di una taverna posta al settimo livello, dove era prevista una lunga sosta.
Qui, davanti ad un calderone di zuppa fumante, ognuno raccontò a turno i propri corviali.
Jorge Kamut raccontò del palazzo circolare di Gora, dove i saggi si disponevano serenamente nell’apparente armonia turchese dei gironi esterni, i filosofi in quelli cremisi più interni, seguiti dai magistrati, disposti in complessi anelli di celle amaranto, poi dai curatori, ordinati in confuse camerate circolari scarlatte, finché si arrivava al centro misterioso e magmatico, al bianco nucleo polare che conteneva tutte le follie del palazzo, ma anche le sue verità e, quindi, il germe della propria rovina.
Un mongolo dal volto bruciato dal sole, frugando nella memoria, ne rinvenne uno nel centro abbandonato di Buyant-Huaa; un arabo ricordò di aver visto qualcosa di simile costruito sulle macerie di quella che fu la superba città di Doha; un vecchio georgiano ricostruì, con poche, energiche frasi, l’immagine del luminoso falansterio di Suhumi, costruito in basalto dorato sulle rive del Mar Nero e distrutto dalle lotte intestine degli abitanti.
In ogni angolo del mondo, si scoprì dopo ventiquattro racconti, l’uomo aveva cercato di dare forma ai suoi sogni e quanto più aveva creduto nelle proprie utopie, tanto più cocente era stata la sconfitta.
Rimaneva, secondo il programma, l’incontro con un gruppo di specialisti che si stavano occupando del restauro della Rovina e del possibile, cautissimo uso sociale di alcune sue parti di minore rilevanza documentaria. I visitatori indugiarono a lungo sui ballatoi a discutere, eccitati, sull’andamento dei lavori e dove questi potessero definirsi propriamente restauro e dove recupero, dove riuso e dove ripristino o risanamento, ristrutturazione, rifacimento, ricostruzione, rinnovamento, miglioria.
In realtà, sebbene il lavoro da fare fosse immenso, l’attenzione era concentrata da anni esclusivamente su di un singolo pannello di facciata rovinato al suolo., Trasportato con ogni cura in laboratorio, il malconcio elemento era divenuto terreno di scontro tra diversi gruppi di ricercatori, con confronti che investivano complesse filosofie d’intervento.
Quando i visitatori arrivarono in vista dei laboratori, cominciarono ad intravedere le sagome di alcuni tecnici in camice bianco presi da viva agitazione. Si trattava di esperti appartenenti a due diverse scuole di pensiero. Un energumeno calvo con il cranio ornato da tatuaggi floreali, sosteneva urlando che il pannello andava ricostruito a l’identique, fregandosene dei poveri resti del materiale originale; l’altro, un milanese smilzo dagli occhi arrossati, ripeteva, resistendo alla gragnola di improperi, che la rovina andava lasciata deperire così come la natura richiedeva, anzi comandava. Tra urla raccapriccianti, si scambiavano insulti terribili (“tardoromantico”, e anche di peggio) estesi alle reciproche famiglie accademiche e padri spirituali. Altri tecnici, divisi in fazioni, si lanciavano oscure minacce condite da volgari allusioni a turpi inclinazioni sessuali dei relativi maestri.
Mentre la guida, passando oltre, semplicemente fingeva di non accorgersi di quanto stava accadendo, i visitatori compresero che i lavori alla Rovina non sarebbero mai terminati.
Uscirono che si avvicinava la sera. Il sole scendeva, glorioso, dalla parte del mare, enorme disco di titanio incandescente sospeso sulle nebbie che cominciavano a salire dai ruderi dell’aeroporto di Fiumicino.
L’urlo lontano di una sirena ricordava la confusione sulla Terra e le prime stelle, alte nel cielo, il supremo Ordine cosmico.
La grande Rovina, ormai priva di vita, mandava un’ombra lunga e lugubre sul fianco della collina che si andava spopolando.
I visitatori erano saliti all’interno di un lucido torpedone a pattini magnetici e si aspettava solo qualche isolato ritardatario per tornare in albergo.
Finalmente l’ultimo turista si affrettò a salire tenendo tra le mani una scatola di cartone. Aveva comperato per pochi centesimi, dal banchetto di un rigattiere, un’ antica sfera di vetro con dentro un Corviale in miniatura che brillava agli ultimi raggi di luce.
Se si scuoteva la sfera una folata di neve sintetica roteava intorno all’edificio di plastica avvolgendolo in una spirale luminosa.