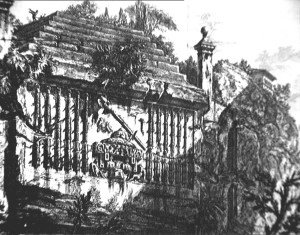di Giuseppe Strappa
in “La Repubblica” del 28/8/1991
Alfio Susini doveva essere un personaggio singolare. Nato al Cairo esattamente all’inizio del secolo da una famiglia di costruttori percorse, giovanissimo, mentre in Europa infuriava la prima guerra mondiale, l’intero Medio Oriente occupandosi, con erratica curiosità, di monumenti arabi, di dighe, di rilievi di edifici: a Gerusalemme, a Nazareth, a Giaffa.
A vent’anni si iscrisse alla Regia Scuola di Architettura di Roma dove docenti e colleghi impiegarono il suo talento di disegnatore in prospettive di maniacale accuratezza. Nella professione si dedicò con discreto successo all’urbanistica ma la sua produzione architettonica fu scarsa e ancor più scarsa la fortuna critica.
A quarant’anni immaginò, tuttavia, un’opera folle e straordinaria, rimasta ineseguita: una singolare porta di marmo, degna conclusione di quella via Imperiale che, attraversata la città di pietra dell’E.42, superata la prima “Porta del Mare” e l’immenso arco di 200 metri sognato da Libera, avrebbe dovuto incontrare a Castelfusano le sabbie ancora deserte di questo tratto del litorale romano.
Fu appunto nel 1940 che il Governatorato di Roma incaricò Susini di occuparsi della sistemazione di questo tratto di costa. All’architetto forse ripugnava, come avrebbero consigliato la vicinanza di Ostia e la natura dell’incarico , pensare ad un luogo per la celebrazione di riti balneari (alle torme di bagnanti riversate dalle corporazioni di regime, alla ricreazione delle comitive dei dopolavoro). Eseguì, è vero, un piano generale di banale funzionalità per i servizi del litorale, ma sembrò dimenticarlo quando disegnò i nuovi propilei . Per questi certamente pensò, invece, alla pineta misteriosa e disabitata dell’entroterra dove appariva , tra fughe contorte di fusti altissimi, il Mediterraneo familiare e lontano. Forse la pineta gli suggerì una nuova fuga di fusti marmorei attraverso i quali osservare il mare, una selva di colonne senza basi né capitelli.
Ma è più probabile che per l’edificio principale, destinato ad una solennità inevitabile, questo italiano d’Egitto, dallo sguardo sognante e un po’ acquoso, avesse immaginato una migrazione, una scheggia dell’E. 42 in costruzione arenata sulle sabbie ancora selvagge del litorale: due torri non alte, una piazza protetta da due ali porticate della quale, nelle splendide tempere del progetto, rari viandanti misurano l’incongruente vastità . Una replica di frammenti di città straniati dal contesto urbano : il mondo esangue dipinto da Susini è in realtà più una trascrizione che una scrittura. Ma una trascrizione sottilmente ingegnosa che, nella contrapposizione senza mediazioni di architettura e natura, coinvolge lo spettatore nelle spire di un racconto di calcolata evanescenza. Anziché gerarchi in orbace si immaginano “alcuni gentiluomini vestiti di nero” aggirarsi tra i colonnati di marmo di un’architettura silenziosa e semplificata all’estremo, attraverso la quale l’architetto allude ad una città esemplare, freddamente dimostrativa, dove gli edifici rimangono senza aggettivi, rifiutano ogni complessità. Una città di forme allo stato aurorale, splendenti nel biancore del marmo contro il cielo blu di Prussia, assurdamente non inquinate da alcun uso prevedibile, dai traffici, dagli scambi. Edifici inospitali, inabitati e inabitabili.
Il paradosso dei propilei che preludono a un immenso vuoto, stretti tra le sabbie e la distesa arborea, crea un’attesa piena d’inquietudine, vicina al “terribile mistero” delle piazze metafisiche. Un racconto nel quale si percepisce, celata, la presenza del tragico senza che il narratore riveli il nodo drammatico della vicenda. Eppure non c’è traccia in questi dipinti di quella linea d’ombra che avanza vittoriosa nelle pitture metafisiche: come in un incubo tenace quella di Susini è una città senza ombre .
Anche la topografia visionaria che ordina la conclusione della via Imperiale sognata dall’architetto ha un rapporto del tutto casuale e trascurabile con la realtà. Non è, dichiaratamente , un luogo geografico, ma una condizione della mente che possiede dell’incubo la rovinosa, insondabile coerenza. La porta che Susini immagina, in altre parole, è pura astrazione: non occupa la periferia remota di una città, ma la periferia smarrita dell’Universo.
Un’architettura, la sua, costretta a difendersi da una natura mitizzata ed ostile (desiderata, e quindi rappresentata, ancora incontaminata) manifestando per intero la propria artificialità, esasperando la durezza di imperativi geometrici rigidissimi e ineludibili contro un mondo vegetale che minaccia la strada verso la città. Strada dalla quale, come in una fiaba, non ci si potrà staccare senza pericolo: per chi percorre il rettilineo in senso inverso , provenendo da Roma ,l’architetto ha previsto nelle piante un faro visibile a distanza, che sembra destinato a rassicurare nella notte più il viaggiatore perso nel mare vegetale che i pescatori della costa.
Ma anche il mondo minerale e civilizzato dall’architettura è tutt’altro che un’isola consolatoria: la piazza è un luogo infinitamente solitario, dove , nella ossessiva regolarità della pavimentazione , ogni passo sembra produrre una nuova eco . Se si deve cercare nella memoria l’immagine di un contrasto altrettanto inquietante tra il mondo civile ed una natura insondabile dove tutto può accadere, più che de Chirico, occorre forse ricordare, per certi versi, le scene finali di Un tranquillo week end di paura. La carcassa d’auto, segno del mondo civile che i superstiti finalmente incontrano al termine del viaggio nell’oscuro continente vegetale del film di Boorman, ha in comune con l’allucinata piazza di Susini l’inquietante qualità di segno, allo stesso tempo, protettore ed infido, di ancora di una salvezza precaria, minacciata .
Architettura sognata e rappresentata, si diceva: relitto della memoria che forse, realizzato, avrebbe deluso le attese. Al contrario di quasi tutti i luoghi costruiti questi volumi abbaglianti, abbandonati al limite di spiagge divenute ormai affollatissime, non sarebbero mai divenuti col tempo necessari e familiari perché, senza dubbio, non ci si attende che una progressiva rovina degli incorruttibili colonnati renda più umana quest’architettura di studiata, immutabile fissità.
Del sogno di Susini rimane dunque solo un bellissimo racconto notturno che la storia, per una volta forse saggiamente, ha risparmiato alla realtà.