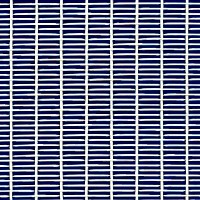FACOLTA’ DI ARCHITETTURA “VALLE GIULIA” – AULA 16 – lunedì 9,30 – 13,30
prof. Giuseppe Strappa, prof. Lina Malfona, arch. Livia de Andreis
il Corso di Figure dell’architettura contemporanea (4 CFU) è collocato al primo semestre dell’anno accademico ed è propedeutico, all’interno del Laboratorio di Progettazione 1, al corso di Progettazione Architettonica 1 collocato al secondo semestre.
Il corso si propone di fornire allo studente, nella prima fase di contatto con i problemi della progettazione, una sintesi essenziale dei temi attraverso i quali si configura la disciplina del progetto architettonico e che verranno affrontati nel corso degli anni successivi.
Tale quadro generale sarà fornito allo studente attraverso cicli di lezioni teoriche ed anche, in modo più diretto, attraverso casi di studio scelti tra quelli che illustrano in modo più diretto i problemi che l’architetto deve affrontare nel corso del progetto:
1. La progettazione come sintesi dei vari aspetti della disciplina architettonica;
2. l ruolo della tipologia;
3. I processi di definizione della forma;
4. La relazione con le preesistenze;
5. Il rapporto con la storia;
6. Il rapporto con la scala urbana e territoriale;
7. La componente tecnica e tecnologica;
8. I problemi della realizzazione;
9. La critica dell’architettura contemporanea come componente del progetto.
Uno o più autori od esperti significativi delle diverse discipline presenteranno la loro opera (progettuale, tecnica, critica) attraverso una comunicazione comune ai tre corsi. Ogni intervento sarà inserito all’interno di una lezione nella quale il docente presenterà il tema.
All’interno del programma generale del nuovo insegnamento, questo corso si articolerà in fasi successive che riguarderanno i molteplici modi nei quali l’architettura, pur nella propria essenza fondamentalmente unitaria, si individua.
L’architettura, infatti, non può essere colta da una sola definizione ma è costituita da un flusso di esperienze (spaziali, costruttive, storiche, estetiche) che si raccolgono intorno al nodo del progetto. Queste esperienze risultano frammentate, negli insegnamenti universitari, in un insieme di discipline le quali, tutte, confluiscono nel progetto, ma delle quali lo studente rischia di non cogliere l’aspetto operante. Poiché gli studi di architettura non sono finalizzati solo alla formazione, ma anche all’educazione al progetto (configurandosi quindi la sede di questi insegnamenti più come scuola che come facoltà) riteniamo che allo studente che si avvicina al suo apprendimento debba essere offerta una “sezione trasversale” del problema attraverso un corso che ne illustri, insieme, la fondamentale unità, ma anche la complessità delle componenti. Questo approccio dovrebbe essere diretto e sintetico, non mediato da una rigida struttura didattica che: un viaggio che, come ogni viaggio, abbia una direzione ed uno scopo, ma includa l’imprevisto, la scelta personale, la scoperta.
Di questo viaggio il corso non vuole essere tanto la guida (ce ne saranno molte negli anni successivi) ma piuttosto un’indicazione e un invito a esplorare.
Intendendo il termine “figura” nel suo senso etimologico (da fingere, plasmare), il corso proporrà tre modi nei quali la realtà costruita, oggetto dello studio, appare e viene letta dal soggetto secondo intenzionalità operative (il progetto):
1. La figura della trasformazione
2. La figura della costruzione
3. La figura del linguaggio
Si cercherà di trasmettere allo studente l’accezione ampia e fertile di queste figure: come la trasformazione, ad esempio, non modifichi solo la realtà fisica delle cose, ma anche il modo nel quale essa si esprime e rappresenta, ponendo il problema di un processo che è, insieme, logico e costruttivo, storico ed estetico.
Il corso tenterà anche di affrontare, ponendo la questione in termini didattici, il problema dell’invenzione, intesa come atto del trovare o dell’incontrare.
I diversi temi verranno affrontati, per questo, attraverso l’impiego di diadi di termini opposti e complementari: non solo la costruzione (da struo, fabbricare per strati) ma anche lo scavo; non solo la trasformazione, ma anche la permanenza; non solo il linguaggio, ma anche la sua assenza nella più generale struttura della lingua (della quale il linguaggio è uso particolare). Non solo il viaggio, quindi, ma anche il suo contrario: la sosta e la riflessione che sono, anch’esse, strumento della conoscenza.
Verranno proposte agli studenti, di volta in volta, letture relative agli argomenti affrontati e visite ad edifici romani, cominciando dall’edificio della nostra Facoltà di Valle Giulia, caso di studio esemplare di mutamento e durata, di tettonica muraria ed elastica, di espressione diretta e mediata.
Lo studente sarà invitato a compilare un “quaderno di viaggio” nel quale prenderà nota, con schizzi e appunti scritti, delle lezioni, conferenze e sopralluoghi proposti dal corso.
L’esame consisterà in una discussione sui temi svolti nel corso sulla base delle note riportate nel “quaderno” presentato dallo studente.