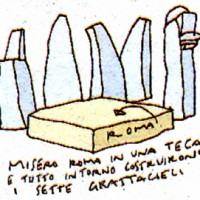di Giuseppe Strappa
in «AR» n° 87/10 gennaio-febbraio 2010
– Mi sembra, prima di tutto, importante sottolineare come l’apertura di questa nostra festa dell’architettura sia iniziata invitando non un’archistar, come qualcuno si aspettava, ma un architetto appartato e fuori moda come Paolo Soleri che ricerca ancora un’alternativa alla spettacolarizzazione del nostro mestiere e, a novant’anni, ci ha trasmesso, con pacatezza, alcune tra le cose più interessanti, originali, e lucide che io abbia sentito in questi ultimi tempi. Credo che questa scelta possa essere di buon auspicio perché la nostra iniziativa trovi una propria strada originale tra le tante kermesse di architettura che ormai proliferano un po’ dovunque.
Roma città plurale: a me sembra che il titolo di questo forum dia adito a diverse interpretazioni, qualcuna fuorviante. Suggerisce, ad esempio, l’idea di un organismo urbano del quale noi cogliamo aspetti diversi e particolari, un organismo fondamentalmente unitario, secondo un’interpretazione che si potrebbe inserire nel grande flusso della tradizione romana della città frammentata, ma unita da una forma generale comune e condivisa. Un’interpretazione che rimanda alle metafore paradossali del tardo antico: Roma come casa che contiene molte città, dove l’immagine organica dell’abitazione esprimeva la visione della forma capace di contenere e, insieme, dare senso al molteplice, alle singole parti divise. Ma anche quella della metropoli contemporanea, che si vorrebbe incomprensibile e che, tuttavia, in fondo, mantiene una propria organicità strutturale, se solo si volesse leggerla, dove le schegge e i brandelli delle lacerazioni sono uniti dallo scheletro delle grandi infrastrutture, dalle arterie e dalle vene del sistema di percorsi che fanno intuire come il multiforme ed il complesso siano il portato di una nuova unità fluida e instabile, che non riusciamo ancora a definire. Ecco, a me sembra che la Roma attuale non sia nulla di tutto questo, che sia, più che una città plurale, un insieme diviso di città. Forse questa specificità ha origine, almeno in parte, nel piano regolatore del ’62 che ha previsto, soprattutto nell’espansione ad est, una città destinata a crescere attraverso insediamenti autonomi, separati da aree verdi, ma riferiti alla struttura unificante del Sistema Direzionale Orientale. Noi abbiamo ereditato le rovine di questo piano, siamo orfani di un’idea di modernità che non si è tradotta in forma. Lo SDO non è mai stato nemmeno iniziato, il verde è diventato i prati di pasoliniana desolazione che conosciamo, aree d’edilizia abusiva, di discariche, smorzi, sfasciacarrozze. I quartieri d’edilizia economica hanno elaborato nel tempo proprie forme di autonoma sopravvivenza, a volte anche decorosa, ma estranee alla vita di una città distante e matrigna. “Vado a Roma” dicono i giovani dei quartieri periferici per dire che vanno al centro, dove c’è tutto quello che manca dove abitano: i servizi, i negozi, il divertimento.
Nonostante tutto, sebbene su quello che sto dicendo siano state innescate infinite polemiche, oggi assistiamo ad un’espansione che prosegue ancora, nei fatti, quella stessa linea dissennata, senza nemmeno l’illusione che il fiume di cemento che si sta riversando nelle periferie, possa avere qualcosa a che fare, almeno, con la città proposta dal movimento moderno quasi un secolo fa e che aveva ispirato un piano già ritardatario nel ’62.
Un’espansione che obbedisce, ancora una volta, alla regola di insediamenti autonomi ma, nei fatti, non autosufficienti, che non formano la metropoli contemporanea, ma nemmeno la continuità della città ereditata, separati gli uni dagli altri, come tante isole che si vanno ormai saldando senza che nessun sistema organizzatore, tra tante polarità rimaste nei piani e sulla carta, le possa realmente integrare. Il problema è di ottica, di prospettive: sembra che non sia possibile pensare che per rovine o frammenti. E’ il trionfo del contingente e del casuale, della trattativa tra politica e promoter sui piani e sui progetti. Le proposte di questi giorni per nuove “cittadelle dello sport”, per esempio, prevedono tutte strutture autonome: migliaia di metri cubi di nuove abitazioni con al centro uno stadio di calcio.
Accettando il compito di mediazione che il progetto à chiamato a svolgere, non ci si è mai soffermati sul ruolo che l’architettura potrebbe avere nel ricostruire i pezzi dispersi delle periferie.
Sembra che il dibattito recente sull’architettura contemporanea si sia concentrato piuttosto sul rinnovo del centro storico. Non riesco a capire per quale ragione, quando si parla di architettura contemporanea e di rinnovamento a Roma, si debba parlare inevitabilmente della sua parte storica. Problema che sembra preoccupare, molto più delle periferie, non solo gli architetti italiani, ma anche quelli stranieri. Dalle dichiarazioni rilasciate dagli architetti che hanno frequentato Roma nella stagione recente, emerge come regolarmente il problema del rinnovamento del centro storico appaia il più urgente tra tutti.
Vorrei soffermarmi su questo problema, non perché sia realmente la questione principale, ma perché è lo specchio delle contraddizioni che vive l’architettura romana contemporanea.
Che il centro storico si debba rinnovare è indubbio: il problema è quale tipo di “contemporaneità” noi dobbiamo prevedere per Roma. Dovremmo considerare con maggiore attenzione, io credo, la nozione contemporanea (contemporanea, non moderna) di “tessuto”, nodo centrale dell’architettura romana estendibile, in forme diverse, dal centro storico alle periferie. L’attenzione al tessuto potrebbe essere il motore del rinnovamento e una scelta assolutamente attuale. La tradizione moderna romana andava, infatti, in direzione diversa. Lo stesso Gustavo Giovannoni, nelle sue teorizzazioni degli interventi su Roma, proponeva esattamente il contrario, la teoria del diradamento, con il monumento al centro ed il tessuto aggregativo di peso trascurabile.
L’importanza della vitalità del tessuto e della sua funzione di lingua comune è una scoperta recente, che risale al dopoguerra. È una scoperta che ci induce a pensare che il bene cui attribuire valore non è solo il monumento (ed estendendo la nozione dal centro all’intera città, non l’episodio straordinario) ma proprio questa radice profonda che dà il carattere all’architettura romana. Una radice che, per intervenire tanto nella costruzione del nuovo quanto nel patrimonio di edilizia storica, bisognerebbe comprendere a fondo e che quasi mai è stata compresa. La quale potrebbe spiegare come i nuovi interventi di architettura “alta”, le opere firmate che dovrebbero dare nuova qualità alla periferia, dovrebbero “derivare” dal tessuto abitativo al contorno.
Nei libri di architettura e in quelli di storia dell’arte ogni edificio firmato da un grande architetto viene interpretato per la sua eccezionalità. Ma basta pensare al palazzo romano per capire come questo non sia altro che l’interpretazione colta di una nozione condivisa di tessuto che costituisce il sostrato indispensabile per comprendere il monumento e per fare architettura. Sono edifici congruenti “necessari”. Basterebbe guardare la pianta dei pianterreno della città di Roma per vedere come tutto obbedisca ad uno stesso modulo derivato dall’abitazione.
Un lavoro utile che potrebbe fare l’amministrazione è ridisegnare, con rigore scientifico, la pianta dei pianterreno della città di Roma. Pianta che potrebbe divenire il palinsesto sul quale ragionare e dal quale trarre indicazioni che, aggiornate alla luce delle nuove condizioni, potrebbero fornire un utile contributo di metodo per progettare il nuovo. Un palinsesto che andrebbe esaminato non col gusto antiquario del nostalgico che vuole riproporre il passato, ma con gli occhi nuovi e spogli di pregiudizi di chi vede i disastri dei contemporanei e si chiede che cosa, della città umana e vivibile, sia andato smarrito.