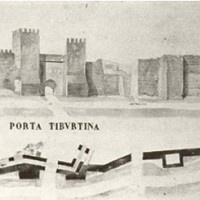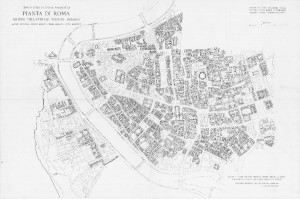di Giuseppe Strappa
in «Corriere della Sera» del 24.08.2002
Bisogna soffrire il sole d’agosto per apprezzare il fascino solenne delle mura imperiali di Roma: liberate dal traffico, esse riconquistano la loro legittima continuità, la scala piranesiana che il fiume sempre in piena delle automobili impedisce di cogliere negli altri mesi dell’anno. E una vasta letteratura è a disposizione, peraltro, del volenteroso che volesse ripercorrere il perimetro di questo monumento unico al mondo. In particolare Ian A. Richmond ha dedicato loro, nel 1930, un volume appassionato e puntiglioso, vera miniera di informazioni alla quale hanno attinto generazioni di studiosi. Ma sulle infinite trasformazioni successive, che costituiscono la parte più enigmatica delle mura, non esisteva ancora uno studio specifico. Un bel libro da poco pubblicato da Rossana Mancini (Le mura aureliane di Roma. Atlante di un palinsesto murario, ed. Quasar) copre ora questa lacuna. Mostrando, implicitamente, come le mura imperiali, costruite precipitosamente in soli quattro anni per far fronte alla critica situazione militare della fine del III secolo, costituiscano, in un certo senso, la prima opera di architettura moderna, testimonianza di una condizione di crisi nella quale l’unità della costruzione e l’impianto regolatore classici non reggono più di fronte alla molteplicità degli eventi, non riescono a impartire ordine alla quantità di edifici che le mura riutilizzano, dall’Anfiteatro Castrense alla Piramide Cestia alla Mostra dell’Acqua Claudia.
E tuttavia le mura sembrano contenere, anche, i germi di un possibile superamento della modernità: il collage di frammenti che oggi si mostra dietro la moltitudine apparentemente eterogenea di rifacimenti e stratificazioni, rivela la continuità epica della costruzione che risorge da qualunque catastrofe ricercando, ogni volta, una nuova, provvisoria organicità.
Esse racchiudono, in questo senso, l’essenza della nozione, tutta romana, di durata: l’insegnamento dell’antico che riunisce, in un unico flusso vitale, una generazione di costruttori all’altra attraverso il lascito trasmesso da saperi e tecniche murarie, perfino quando i laterizi ricavati dallo spoglio di anfiteatri e terme non erano più reperibili e, dal XII secolo, come rileva Giovanni Carbonara nell’introduzione all’Atlante, i metodi si adeguano all’impiego di materiali poveri: selce, tufo, peperino, frammenti di marmo e di travertino. Non è un caso che le mura siano state abbandonate solo nel periodo di maggiore decadenza civile di Roma, nell’età del Medioevo selvaggio e feudale che aveva diviso la città in fazioni familiari arroccate nelle proprie abitazioni fortificate.
Irrappresentabili, per complessità e dimensioni, con un’immagine “mediatica” rapidamente comunicabile, le Mura Aureliane mal si prestano, per nostra fortuna, a divenire oggetto del turismo frettoloso che ha invaso gli altri monumenti di Roma antica. Forse per questo sono state trascurate per decenni.
Eppure esse costituiscono un’eredità fondamentale, il confine capace di restituire, ancora ai nostri giorni, identità e forma finita alla città storica. Proprio per questa loro singolarità le mura dovrebbero essere visitate, soprattutto, attraverso il camminamento di ronda che permetterebbe di coglierne il senso e la continuità. I dodici interventi di restauro finanziati con i fondi del Giubileo, peraltro eseguiti a regola d’arte, avrebbero dovuto in parte consentirlo. Invece, ironia della sorte, anche l’unico tratto percorribile, tra Porta S. Sebastiano e i fornici sulla via Colombo, è stato interrotto, ormai da molti mesi, da un rovinoso crollo e forse dovremo aspettare il prossimo Giubileo per vederlo ripristinato.